• «Sono due razze diversissime, non amalgamabili, anche perché l’Adige ha sempre impedito ogni forma di socializzazione» osserva don Boscagin • «Già don Trecca aveva cominciato a scrivere questa storia, ma si fermò al 1500» • «Sulle bozze dell’ultima dispensa scrisse, in latino: “Mi sono cadute le mani”. Io ho ripreso da lì» • «Città militare, cinta da mura, Legnago è stata per amore o per forza autosufficiente e quindi un po’ chiusa» • «E infatti i legnaghesi erano classisti e avevano il caffè degli avvocati, quello dei dottori, dei commercianti, degli operai» • «Prima di morire voglio realizzare un paio di cose» • «Ho pronto un libro sui personaggi illustri, ma non trovo lo sponsor per pubblicarlo» •
Il seme della passione per la storia («non la grande Storia — precisa — ma quella con la “s” minuscola, dei piccoli episodi, quella che riguarda più da vicino la nostra terra, che ci insegna a riconoscere le nostre origini e a percorrere il nostro cammino, passo passo nei secoli, e che ci fa amare ancora di più la nostra Bassa») don Cirillo Boscagin confessa di averla sempre avuta segretamente dentro. «Da ragazzino — dice — passavo giornate intere nell’archivio della parrocchia. Poi cominciai a scrivere qualche articolo per i giornali locali. Erano episodi di precisa collocazione storica, senza pretese».
Ma fu il compianto prof. Gino Beltramini di Verona a far sbocciare nel tranquillo cappellano dell’ospedale di Legnago la «grande» passione, quando, nel 1952, gli chiese un articolo da pubblicare nella rivista «Vita Veronese», in occasione del centenario del martirio di Frattini e Scarsellini.
«A Beltramini il pezzo piacque — ricorda don Cirillo — e mi chiese di preparare per la collana “Le guide” una breve storia di Legnago, che venne pubblicata nel 1956 e che in breve esaurì due edizioni».
La ricerca divenne ben presto, per don Cirillo, molto più di un hobby. «Il mio impegno con l’ospedale — sottolinea — mi lasciava parecchio tempo libero. Presi a frequentare la Fondazione Fioroni, gli archivi di Verona e di Venezia, numerose biblioteche, alla ricerca di notizie, documenti, scampoli della storia di Legnago. Intanto moriva don Trecca, l’eclettico, enciclopedico, caustico, “strano” sacerdote della Bassa che cento cose iniziava e non una ne portava a termine. Aveva cominciato, fra l’altro, a pubblicare a dispense, intorno al 1900, una bellissima storia di Legnago, ma si era fermato all’anno 1500 circa. Il resto del materiale, sparso, era presso la Fioroni, che mi incaricò di riordinarlo. Scoprii così che don Trecca aveva provato a terminare l’opera, ma poi si era arreso, scrivendo una frase lapidaria sulle bozze dell’ultima dispensa, mai pubblicata: “Hic cecidere manus”, cioè “mi sono cadute le mani”. Si era insomma stufato, come in tutte le sue cose. Presi il materiale, lo riordinai, aggiornandolo e completandolo ed arrivai a pubblicare, nel 1966, la prima edizione della “Storia di Legnago”, con la presentazione del legnaghese prof. Gino Barbieri, edita da Ghidini e Fiorini e con il patrocinio della Cassa di risparmio, che intervenne con un contributo di due milioni di lire a fondo perduto. La prima copia dell’opera fu presentata al ministro Gui, il cui nonno era stato per anni casellante delle Ferrovie nel Legnaghese».
In pochi anni la «Storia di Legnago» andò esaurita. Nel 1975 don Boscagin ne pubblicò la riedizione riveduta e corretta, con il titolo «Legnago nella storia», la nuova presentazione di Gino Barbieri, stampata da Girardi di Legnago, ancora con un sostanziale contributo della Cassa di risparmio. E anche il secondo libro andò a ruba. «È servito a insegnanti e studenti per le tesi di laurea — osserva don Cirillo —. Quindi si è presentata la necessità della terza rispatampa, che uscirà a giorni e che sarà aggiornate, corretta, ampliata nella parte socio-economica. La realizzazione della nuova opera, in due volumi, corredata di nuove illustrazioni, è stata resa possibile grazie all’interessamento della Pro Loco di Legnago». È bene ricordare che don Boscagin, oltre all’imponente «Storia di Legnago», che ha raccolto, fin dalla pubblicazione della prima edizione, un lusinghiero successo di pubblico e di critica, è autore di altre pregevoli opere.
Recente (1982) un libro sulla storia degli ospedali a Legnago, edito da «La Mainarda» di Cologna Veneta. Dell’80 è «Una nobiltà a servizio dei poveri: fratel Francesco dei conti Perez» («un uomo umilissimo — annota l’autore — che donò tutti i suoi beni e fece voto di povertà per stare vicino a don Calabria, nel corpo e nello spirito, e che quasi certamente sarà beatificato»).
Ha vent’anni (1964), invece, un’altra pubblicazione sulla vita di monsignor Girolamo Cardinale, che fu vescovo di Verona e che ricorre spesso nel pensiero di don Boscagin, essendo stato per sua mano ordinato sacerdote.
Don Cirillo è innamorato della «sua» Legnago, dove operò per oltre trent’anni e di cui ricorda la gente, la vita, le speranze, l’evolversi del progresso del dopoguerra. «Ma a Legnago — racconta — ero di casa fin da bambino, quando mi accompagnavano al mercato. Legnago ha un ambiente tutto particolare; si sente città e rivendica questo ruolo in virtù di ragioni storiche che la resero indipendente da Verona fin dal 1399, ad opera di Gian Galeazzo Visconti. Legnago non sente legami di dipendenza da alcun centro, anche perché fu sempre città militare, fortificata, cinta da mura e quindi per amore o per forza autosufficiente. Nel bene e nel male, l’indipendenza, le mura, l’acqua, segnarono la storia di Legnago e condizionarono la mentalità dei suoi abitanti».
Appunto, la mentalità. Don Boscagin sostiene che essendo Legnago città militare per tradizione, e quindi «chiusa» alle innovazioni, all’industria e anche ai commerci, è stata condizionata da questi fattori nel suo modo di agire e di pensare. Per lo meno fin o a un paio di decenni fa. «I legnaghesi, fino a poco tempo fa — spiega — erano quasi classisti. C’era il caffè degli avvocati, quello dei dottori, dei commercianti, degli operai. Non parliamo poi delle lotte tra Porto e Legnago, divise, prima ancora che ci fosse l’Adige, da un altro corso di fiume. Gli abitanti dei due centri non sono mai riusciti a sopportarsi a vicenda. In passato ci furono vere e proprie lotte; ora tutto questo si è ridotto magari a un simpatico campanilismo, ma fino a poco tempo fa non scherzavano. Io mi spiego questa insofferenza tra Legnago e Porto con il fatto della diversa origine dei rispettivi abitati. È provato da reperti archeologici, infatti, che Porto fu originata da una civiltà atestina, veneta, metnre Legnago ha ascendenze etrusche. Quindi due razze diversissime, non amalgamabili, anche perché l’acqua dell’Adige ha sempre impedito ogni forma di socializzazione tra le due parti. Un vecchio parroco mi diceva addirittura che si poteva notare la differenza di linguaggio, di qua e di là del fiume. D’altra parte, alcuni verbali comunali del Quattrocento o del Cinquecento, a Porto (che allora era Comune autonomo) si trovano scritti in forma dialettale, mentre a Legnago, città colta, sono scritti in perfetto latino. Vuol dire che si parlava in maniera diversa. E a ben vedere, questa diversità, in alcune espressioni, in alcuni modi di dire, si nota ancora oggi».
Ma il fatto che Legnago rimase sempre racchiusa all’interno delle sue mura, fino al 1887, quando vennero abbattute («e si compì il delitto di demolire e disperdere i resti delle due porte del Sanmicheli», geme don Cirillo), non le impedì di essere spesso una città all’avanguardia per cultura ed iniziative. «Basti pensare all’ospedale, di tradizioni antichissime — spiega l’autore della “Storia di Legnago” — o al monte di pietà. Legnago fu la prima, a quanto risulta, ad istituire una borsa di studio per due medici che andassero a Padova a studiare per poter curare le numerose malattie contagiose che vi erano a causa, soprattutto, del fosso che cingeva le mura e delle risaie che, nonostante la legge lo vietasse, arrivavano a ridosso della città».
Per don Cirillo, Legango, comunque, può andare giustamente fiera della tradizionale laboriosità e tenacia dei suoi abitanti. «Ha sempre saputo superare — dice — i momenti difficili. E ne ha avuti tanti. Dalla distruzione operata da Ezzelino da Romano, alle varie inondazioni, alle bombe dell’ultima guerra. Fino ad arrivare ai primi del Novecento quando, alle secolari tradizioni del mercato e del commercio fluviale, sfruttando la sua posizione privilegiata, al centro di importanti vie di comunicazione, in una zona che era la prima che si rendeva abitabile oltre le Grandi Valli, piano piano seppe scoprire l’industria dello zuccherificio, che fu il secondo ad essere realizzato nell’alta Italia».
A quasi ottant’anni, don Cirillo coltiva ancora l’hobby della storia, passando ore e ore nel suo studio. «Prima di morire — dice — voglio arrivare a realizzare un paio di cosette che ho in cantiere. Ho pronto un libro sui personaggi illustri di Lengago, dei quali io ho curato la biografia e Felice Nalin ha realizzato il ritratto in maniera stupenda. Ma non trovo lo sponsor… Inoltre, vorrei tanto pubblicare un calendario storico che mi è costato molto lavoro, ma che penso potrebbe interessare a molti. Ogni giorno narro un episodio di vita legnaghese di storia spicciola che ha una relazione con quella certa data». Una sorta di diario retrospettivo in cui ogni legnaghese insomma potrebbe «leggere» un pezzetto della sua storia fino al 1982. Lanciamo un’idea al nostro giornale: non si potrebbe «rubare» il manoscritto? Don Cirillo Boscagin, ne siamo certi, farebbe finta di non accorgersene.
Franco Bottacini
(L’Arena, 1984)






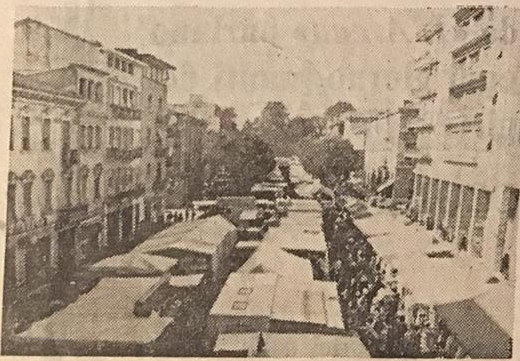
 C’è una parola che, negli ultimi dodici mesi, ha spopolato sui mezzi d’informazione. È selfie, eletta
C’è una parola che, negli ultimi dodici mesi, ha spopolato sui mezzi d’informazione. È selfie, eletta